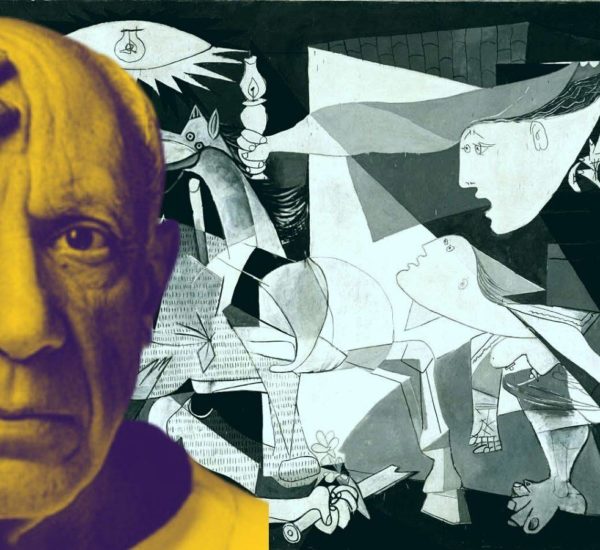Lettura immaginale del quadro di Rembrandt e dell’immigrazione
Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l’emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente, ma non a farli scomparire. (Zygmunt Bauman, La società sotto assedio, 2018)
Migrare. Un verbo che già di per sé contiene un racconto. E come ogni racconto è accompagnato da emozioni variegate: ansia, paura, curiosità, euforia… terrore. Si emigra per fuggire e cambiare. Si immigra per cercare. Da sfondo a questi viaggi ci sono uomini e c’è la natura, categorie che sanno essere sia benevole che maligne. All’immigrazione si può rispondere con accoglienza o con repulsione.
Il viaggio in mare è da sempre un simbolo.
Per viaggiare in mare si deve osservare il cielo: il mare in apparenza non dà punti di riferimento.
Il viaggio in mare è un viaggio nell’ignoto, è un passaggio in un mondo parallelo.
L’acqua in tutte le sue forme – in quanto mare, lago, fiume, fonte ecc. è una delle tipizzazioni più ricorrenti dell’inconscio, così come essa è anche la femminilità lunare che è l’aspetto più intimamente connesso con l’acqua (C.G. Jung,1990, «Mysterium coniunctionis», in Opere, vol. XIV, p. 285)
Chi esce dal mare è simbolicamente carico di mistero. Il migrante del mare è un’interferenza con la vita della terra ferma: letteralmente, è una persona che porta intorno, porta la sua storia e le coordinate di mondi lontani. Forse è per questo che a molti fa paura. Siamo abituati alle certezze della terra ferma. Ci ancoriamo ai nomi delle strade e delle città per assegnare confini alla nostra esperienza. Ma chi immigra “in casa nostra” viaggiando in mare esula da questa logica. È un’interferenza di mistero.
Cristo nella tempesta sul mare di Galilea
Oggi vorrei guardare un dipinto che esprime una lotta continua tra la forza della natura e le emozioni dell’uomo, in un viaggio per mare. Nel guardare la barca colma di uomini del dipinto di Rembrandt “Cristo nella tempesta sul mare di Galilea” (1633), siamo messi di fronte all’allegoria di tutte le barche che ogni giorno attraversano i mari che ci circondano. Sono barche colme di uomini, donne e bambini. Barche cariche di vita e di morte. Di sangue e di speranza. Sono le barche dell’immigrazione.
Che sia sui social, al Tg, in una quotidiana conversazione per strada non facciamo altro che incontrare questa parola. Ultimamente sembra accompagnarci un po’ ovunque. Immigrazione è un termine entrato nei vocabolari quotidiani dalla caduta del muro di Berlino. Muri, barriere, confini, porti…sono i luoghi delle migrazioni; molto spesso il mare ne è la strada.
Il viaggio per mare
Da sempre la barca è stata espressione di un archetipo, colei che ci porta nel nostro viaggio terreno da una sponda all’altra. L’io che nel viaggio individuativo deve confrontarsi e relazionarsi con le intemperie che il destino ci pone sul nostro viaggio. (A. Romano, Il vecchio di Bollingen, intervista a Dieter Baumann in «Anima», 2000)
Per poter viaggiare in mare ci sono barche e zattere, velieri e gommoni.
Viaggiare in mare è perdere i punti di riferimento a cui siamo abituati. Chi si trova oggi in balia delle onde si sente separato dal grande universo. Può pensare di essere parte di un altro mondo, un mondo abbandonato al proprio mare che diviene simbolo di morte. E noi siamo capaci di confrontarci con tutto ciò?
Rembrandt ci pone un interrogativo mentre dipinge una parabola evangelica. Dà forma a una scena di viaggio, di vita. Un mare in tempesta tiene in balia una barca. Moto e quiete si scontrano. È un dipinto spezzato in due: tempesta e sole; panico e quiete; operosità e staticità. Diversi critici d’arte sostengono che l’unico soggetto nel quadro che sembra guardare l’osservatore sia il pittore stesso. Rembrandt ha dipinto se stesso su quella barca. Un personaggio sembra guardare lo spettatore. Sembra chiederci come reagiremmo in una tempesta. Oppure sembra cercare la quiete all’esterno del quadro.
Cristo nella tempesta sul mare di Galilea è il racconto di una crisi, fisica e interiore.
I flutti sembrano inghiottire la normalità. Il mare tenta di far scomparire le certezze. E nel buio delle nuvole e del mare si nasconde l’indice di un Maestro a indicarci la luce che squarcia la tempesta. La barca nel dipinto segue la linea dell’albero; cerca di salvarsi e salvare attraverso l’inclinazione dell’albero. L’albero, simbolo di vita e di linfa vitale. Allo stesso filo di vita si aggrappa il migrante. Quell’albero della nave che diviene sinonimo dell’asse del mondo e di una salita verso l’alto.
Rembrandt crea un dipinto che esprime una lotta continua tra la forza della natura e le emozioni dell’uomo, con una morale finale: tentare di restare a galla.
Proviamo a leggere quest’opera come un quadro di migrazione. Immaginiamo la scena di una tempesta in un gommone o in un peschereccio. E al posto di uomini in abiti medievali sostituiamo donne, bambini e uomini. Gli “uomini neri” venuti dal mare.
Se ci concentriamo sul ruolo di spettatori del quadro e della sua allegoria di immigrazione, il quadro si trasforma in uno scontro di archetipi e di miti. Uno scontro di mistero, di ignoto e di inquietudine con la speranza di un bagliore di sole e della quiete dopo una fragorosa tempesta. Con uno dei migranti che ci guarda e ci chiede qualcosa che non riusciamo a capire.
Chi guarda il dipinto può sentire il rumore delle onde, l’odore del terrore, il desiderio di un miracolo, di qualcuno che calmi il tumulto delle onde e che ci conduca alla salvezza.
Un immigrato dentro di me
Ognuno di noi dovrebbe immaginarsi tra la gente che migra, dovrebbe immaginarsi di essere tra quelle vite sospese. Dovrebbe immaginarsi di essere vicino soprattutto ai bambini migranti o ancor di più di essere quel bambino migrante. Il personaggio che guarda verso di noi, chiede un processo di empatia e di immedesimazione: il primo passo per costruire un molo d’approdo. Sì perché l’approdo è un processo psicologico, non solo un luogo materiale.
Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. (Don Lorenzo Milani)
Ogni migrazione, che sia di popoli, di uomini, di idee o di processi interiori, è una nostra immigrazione. L’altro che solca il mare ed entra nei confini delle terre che abitiamo sta immigrando nel nostro microcosmo. Noi possiamo scegliere se e come integrarlo.
Ogni singolo approdo dipende da noi. Ogni approdo è una rinascita. Rinascita di chi arriva, nuova nascita di chi accoglie. Tutti siamo un po’ degli Edipo a Colono in cerca di un re Teseo che ci dia accoglienza. E tutti avremmo bisogno di un Cristo che calma le acque come nel dipinto.
Conclusioni
Il quadro di Rembrandt e la parola immigrazione, ci pongono di fronte a una sfida complessa. Ci danno un potere sovrumano. Oggi, nella realtà del quotidiano, oltre a essere passivi spettatori, Possiamo scegliere se far essere il mare delle migrazioni un mare simbolo di vita e di rinascita o restare inconsapevoli che l’acqua del mare si può tingere in un attimo di rosso sangue. Possiamo trasformare l’interferenza venuta dal mare, integrandola nei nostri sistemi. Possiamo accorgerci che l’ “uomo nero”, ci fa paura perché è un interferenza nel nostro sistema di abitudine. L’uomo nero che esce dal mare, simbolicamente, può rappresentare la più grande paura del nostro inconscio … ma una paura che, una volta abbandonata la nostra anima, possiamo integrare in Noi.
Norman Rice diceva che bisogna avere il coraggio di posare la nostra mano nel buio, per portare un’altra mano alla luce.
Rembrandt ci guarda e ci chiede: “Tu cosa faresti al posto mio in questo naufragio”?
P.S. Se ti è piaciuto l’articolo CLICCA QUI per leggere la lettura immaginale del Bacio di Klimt!